Recensione di “Delitto e castigo” di Fedor Dostoevskij
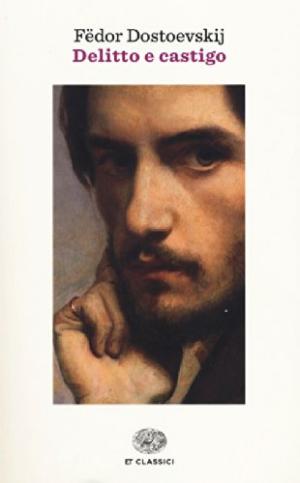
Che cosa determina la moralità di un’azione? L’intenzione con la quale la si pianifica e poi la si mette in atto? Il fine, lo scopo che persegue? Le conseguenze cui approda? Le risposte della coscienza? E può, la coscienza, legittimamente dirsi giudice di quel che viene compiuto? Possono i suoi tormenti testimoniare la verità del male inflitto e i suoi silenzi esser prova d’innocenza?
È nella distanza che separa la disincarnata perfezione dell’idea dalla sua realizzazione che riposano il giusto e l’ingiusto? In una cornice di profonda miseria materiale, che è insieme materiale narrativo e angoscioso richiamo a una situazione personale, questi interrogativi stanno a fondamento di Delitto e castigo, una delle opere più note del grande romanziere russo Fedor Dostoevskij. Nella parabola esistenziale ed etica del protagonista, il giovane studente Raskol’nikov, che, colmo di amaro risentimento, senza sosta si dibatte in oscuri pensieri, dove si confondono, come in un delirio, rivendicazioni di giustizia sociale e violenti desideri di rivincita e affermazione, l’autore disegna quella di un’intera generazione; Dostoevskij guarda alla Russia del suo tempo, incendiata da nuove teorie, vibrante d’entusiasmo e piena di paura, attratta dalla radicalità spavalda del nichilismo e timorosa di perdere il proprio ancestrale legame con la terra, con l’essenzialità del sapere contadino, con la memoria ruvida e sincera del popolo.
In Raskol’nikov, dunque, e nei personaggi che attorno a lui ruotano, nei caratteri che compongono lo splendido affresco dostoevskiano – l’usuraia che finisce vittima tanto della rabbia e del risentimento del ragazzo quanto del suo distorto bisogno di equità, nell’affaticato vivere e amare di sua sorella Dunia, e ancora nel sacrificio sovrabbondante di nobiltà e sofferenza di Sonja, vero contraltare di Raskol’nikov e strumento della sua salvezza, nelle figure di Razumichin, Luzin e Svidrigajlov, che, nelle loro macroscopiche differenze, rappresentano altrettante istanze dell’universo morale dell’uomo, altrettanti aspetti del suo modo di interpretare il mondo, di cercarne un senso – giungono a scontrarsi e a deflagrare temi di portata universale, dinanzi ai quali le misere trame del vivere, gli espedienti, le viltà, sono gli abiti laceri, i consumati fagotti che malamente proteggono tesori di eccezionale valore, le sole cose che davvero hanno significato: le scelte che si che si fanno, e le ragioni che le sostengono.
Nella trasfigurazione letteraria di Fedor Dostoevskij, dunque, che arriva a dar vita a un “romanzo criminale” per poter raccontare, al di là della tragedia fin troppo umana del mero fatto di sangue, il calvario di un’anima e attraverso esso il fondamento di quel che siamo, il romanzo supera se stesso; il linguaggio, lungi dall’esaurirsi nel compito di dar forma all’intreccio, di continuo rimanda ad altro da sé; dietro ogni confronto, nella febbre solipsistica di Raskol’nikov come nei suoi confronti con amici e conoscenti, nella disarmata saggezza di Sonja come nell’esibita, compiaciuta abiezione di Svidrigajlov, quel che si apre dinanzi al lettore è l’infinito della riflessione, l’atto puro dell’indagare. Come una terra talmente fertile da lasciare senza fiato per la messe dei frutti che riesce a offrire, la prosa di Fedor Dostoevskij sembra moltiplicarsi, arricchirsi, crescere; il romanzo, nel suo svilupparsi, si svela in tutta la sua complessità, e la storia, senza smettere di avvincere, coinvolgere, commuovere, è come se si facesse da parte per lasciare spazio all’approfondimento etico e subito dopo al rapporto tra colpa, punizione e riscatto, alle sue “ricadute” giuridiche e ancor di più al legame che tutto ciò ha con il rimorso, l’espiazione, con l’equilibrio di ragioni e torti pesato sull’imperscrutabile bilancia della giustizia divina, e di nuovo tornasse a mostrare il proprio volto (anzi la propria maschera) il tempo necessario a richiamare l’attenzione su altro: sulla maligna seduzione di un pensiero nato solo per distruggere, sulle insidie che porta con sé qualsiasi palingenesi che abbia la pretesa di rifondare ogni cosa dal nulla, sulla necessità e i limiti di un approccio alla vita che si richiami alla luce della ragione. Filosoficamente scomposto, ridotto all’essenza, al proprio nucleo primo e indivisibile, ecco l’uomo (e il suo essere nel mondo), illuminato dal talento di Dostoevskij, dalla sua penna miracolosa, implacabile come la lanterna di Diogene.
Eccovi l’incipit. La traduzione, per Einaudi, è di Alfredo Polledro. Buona lettura.
In una giornata estremamente calda del principio di luglio, verso sera, un giovane scese in strada dalla stanzuccia che aveva in subaffitto nel vicolo di S. e lentamente, come fosse indeciso, s’avviò verso il ponte di K..