Recensione di “La capanna dello zio Tom” di Harriet Beecher Stowe
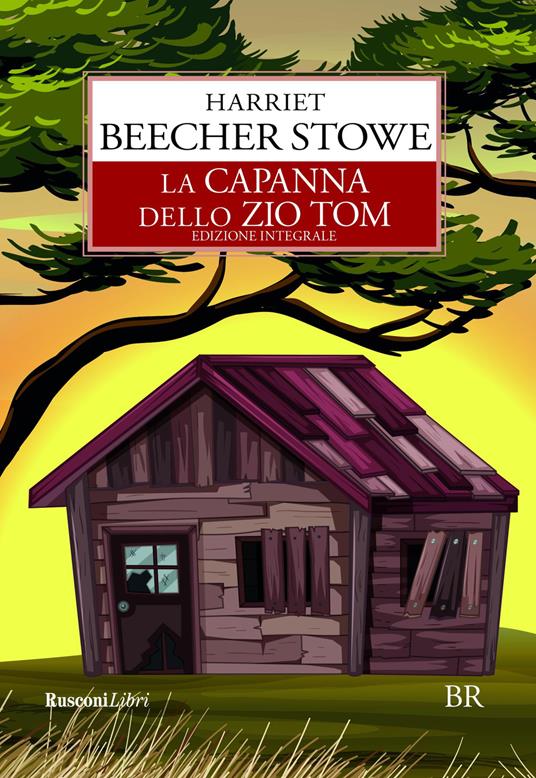
Restituire la complessità dei personaggi (i protagonisti come i comprimari) che animano
un romanzo significa penetrarne le sfumature, illuminarne le zone d’ombra, ma soprattutto riuscire a dare vita a quelle particolari situazioni che sole favoriscono (e alle volte addirittura scatenano) una risposta che non ci aspetterebbe da chi, fino a quel momento, si è condotto in un certo modo e che proprio per questo, lungi dal rappresentare una contraddizione o peggio dal rivelarsi un vero e proprio infortunio in cui il narratore cade, ne evidenziano invece l’abilità, il talento, perché offrono un ritratto non solo verosimile ma, ed è ciò che maggiormente conta, quanto più possibile completo del carattere che viene rappresentato. In una parola, se mettere in scena le tortuosità e finanche gli sbandamenti morali di chi, a seconda delle circostanze in cui viene a trovarsi, opera tanto il bene quanto il male (pensiamo per esempio a tutti coloro che uccidono per vendetta, o tradiscono per paura) è, nella narrativa, prova di raggiunta maturità, ne consegue che l’opposto, cioè la costruzione di una vicenda i cui attori si distinguano fin da principio in buoni e malvagi sulla base delle loro scelte (sempre giuste quelle dei primi, sempre odiose quelle dei secondi), testimonia quantomeno una certa colpevole ingenuità, perché si sa che nessun uomo è fino in fondo e completamente virtuoso o vizioso. Ma è davvero così che stanno le cose? Davvero un protagonista radicalmente cattivo (attraverso il quale non si intende certo simboleggiare un singolo uomo ma ciò che di riprovevole, di ignobile, l’umanità, il consesso umano porta in sé come parte della propria essenza) può al massimo suscitare sorrisi di condiscendenza? E davvero qualcuno che sia solo e soltanto buono (che ancora una volta non rimanda a nessun uomo particolare ma agli uomini tutti), nella cui anima non alberghi alcun pensiero che non sia d’amore e compassione, è condannato a essere una creatura di sogno, alla non esistenza? Verrebbe da rispondere di no guardando a come caratteri come quelli appena descritti, del tutto privi di tentennamenti, votati per intero alla luce o all’oscurità, siano la spina dorsale (perché consapevolmente costruiti in questo modo) di un’opera a buon diritto considerata un classico della letteratura, letta e ammirata da generazioni e che Tolstoj qualificò come qualcosa di talmente grande da “restare per secoli”: La capanna dello zio Tom, manifesto abolizionista di Harriet Beecher Stowe.
Se è più che superfluo soffermarsi sulla trama di una storia universalmente nota, molto meno lo è analizzare quello che sembra, da quanto fin qui detto, un difetto esiziale dell’opera, e cioè il suo voler dipingere ogni personaggio (a partire dal negro totalmente buono che compare nel titolo, quel Tom che è lo schiavo più amato della piantagione in cui vive e lavora, un luogo anch’esso quasi paradisiaco – siamo nel Kentucky alla metà del XIX secolo, di lì a qualche anno l’America vivrà la lacerante, terribile esperienza della guerra civile, eppure il piccolo mondo di Tom, dei suoi compagni schiavi che tutto sono tranne che esseri umani in catene costretti a lavori massacranti e trattati alla stregua di bestie da soma, e dei loro padroni che del padrone non hanno nulla e invece somigliano ad amorevolissimi genitori preoccupati del benessere delle proprie creature, gli schiavi per l’appunto, è descritto in modo quasi idilliaco) come se fosse capace di un unico sentimento, perché non certo di difetto si tratta, bensì del suo maggior punto di forza. L’autrice infatti, convinta avversaria del sistema schiavista, nel denunciare un’ingiustizia così macroscopica e intollerabile pone con estrema forza l’accento sugli eccessi che una perversione di tal fatta inevitabilmente crea, eccessi che giungono a trasformare coloro che li incarnano (gli uomini, le donne, i bambini, l’umanità insomma) in qualcosa di assurdo, di mostruoso. Al pari di chi, ci dice la Stowe attraverso i suoi personaggi così perfettamente monodimensionali, esposto a una sostanza velenosa non può non subirne gli effetti nel corpo e nello spirito, tutti coloro che contribuiscono non solo al mantenimento ma alla prosperità di un abominio come la schiavitù da quella disumana logica vengono presto o tardi travolti (immediatamente se la condividono, un po’ più in là nel tempo se mettono a tacere per convenienza o per timore le loro iniziali perplessità ma la sostanza, in entrambi i casi, non cambia). Allo stesso modo, coloro che vi si oppongono, per la sola ragione di aver compiuto la scelta giusta (e dunque la più difficile) in un momento in cui schierarsi da una parte invece che dall’altra non può portare che difficoltà e pericoli, si vestono di una pietà che supera in intensità ogni altro sentire e si fa guida indiscussa di ogni loro passo. Per questo e non per altro, per la limpidezza delle posizioni prese (e per le conseguenze che da esse derivano), Tom, Shelby, la famiglia Harris, Haley, Legree sono ciò che sono: simboli dell’eterno ascendere e cadere dell’umanità.
Eccovi l’incipit, buona lettura.
Era una giornata freddissima del mese di febbraio, e nella citta di P…, nel Kentucky ad aora già avanzata due gentlemen, seduti col bicchiere in mano in una ricca sala da pranzo, liberi dall’incomoda presenza dei servi, discorrevano con molto calore sopra un argomento di alta importanza.