Recensione di “Buio a mezzogiorno” di Arthur Koestler
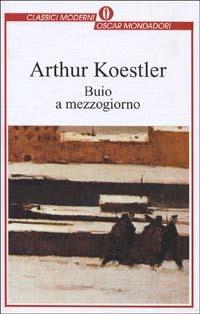
Se si assume a principio etico del proprio agire la fin troppo celebre affermazione che
vede il fine che si intende raggiungere sempre giustificato (quali che siano i mezzi utilizzati per arrivare al traguardo), allora si può dire che non esiste, a fondamento di ciò che si compie, alcuna moralità; o all’opposto si può sostenere che non ci sia legge più nobile e severa di questa, che chiede a coloro che la applicano assoluta fedeltà a un’idea, nella certezza che sia non semplicemente quella giusta (o una giusta tra altre) ma la sola possibile, l’unica via di salvezza per gli uomini tutti. In quest’ultimo caso un agire così condizionato e del tutto privo di pietà può essere considerato “storico”, perché è storia, cioè qualcosa di eterno, ciò che si raccoglie da simile semina; tuttavia, qual è la storia che emerge da questo sforzo allo stesso tempo inumano (o per dir più esattamente antiumano) e talmente utopico da apparire misericordioso? A giudizio dell’ex commissario del popolo Nikolaj Salmanovic Rubasciov, protagonista del notissimo romanzo Buio a mezzogiorno di Arthur Koestler (Mondadori, traduzione di Giorgio Monicelli), che con tutto se stesso ha incarnato l’imperativo del “bene superiore” da ottenere a qualsiasi costo per poi arrendersi alla semplice realtà delle cose, impermeabile a ogni analisi, irriducibile a qualsiasi teoria, e che nei secoli, nella sostanziale uniformità del tempo, non chiede per sé se non un bene che la filosofia chiamerebbe sensibile, intendendo con questo termine ciò che si può conoscere con i sensi, che si arriva a percepire senza alcun particolare sforzo, che esiste nel presente, che possiede l’immediatezza della risposta e non l’evanescente soffio della promessa, di qualcosa che giungerà, infallibilmente giungerà, anche se nessuno è in grado di dire quando. Arrestato, da un giorno con l’altro, proprio da coloro accanto ai quali aveva lavorato fino a un momento prima, Rubasciov ha modo di ripensare al suo passato, ai sacrifici fatti, ai compromessi accettati, ai tradimenti di cui si è reso responsabile (sempre in nome di qualcosa di più grande, il cui valore annulla quello di qualsiasi altra cosa, o persona, o popolo) Rubasciov ingaggia con coloro che non riesce più a considerare fratelli ma che ancora non ha trasformato in avversari (mentre loro questo passo lo hanno già compiuto, chissà se per mero calcolo o per adamantina ortodossia politica) vertiginosi, labirintici duelli verbali la cui selvaggia crudeltà ha il sapore di una caccia all’uomo. Uomo destinato a essere preda in luogo di ciò che è e rimane inafferrabile: la verità.
Così, colui che fu uno dei massimi dirigenti di una dittatura costruita “a beneficio delle masse” (l’evidente riferimento dell’autore è al regime staliniano e ai suoi orrori, ma al di là dell’individuazione del contesto storico il romanzo ha un respiro ben più ampio e riflette sul senso di ogni idea che abbia a proprio fine la costruzione di un “mondo nuovo”), di fronte al compagno di torture inflitte a decine e decine di “colpevoli”, di “controrivoluzionari” ora divenuto suo carceriere, dichiara: “Le masse lasciamole da parte […]. Una volta, quando il grande ‘noi’ esisteva ancora, noi le capivamo come nessuno le aveva mai capite prima […]. In quel tempo […] eravamo chiamati il Partito della Plebe. Che sapevano gli altri della storia? Lievi increspature, vibrazioni fuggevoli, ondine rompentisi. Si soffermavano a guardare le forme mutevoli della superficie e non sapevano spiegarle. Ma noi eravamo discesi nel profondo, nelle informi masse anonime, che in ogni tempo hanno costituito la sostanza della storia; e fummo i primi a scoprire le sue leggi del moto […]. Questa è stata la grandezza della nostra dottrina. I giacobini erano dei moralisti: noi siamo stati degli empirici. Abbiamo scavato nel limo primordiale della storia e vi abbiamo trovato le sue leggi. Abbiamo saputo più di quanto gli uomini abbiano mai saputo del genere umano […]. Ed ora avete riseppellito tutto quanto“. Nell’insuperabile dicotomia tra politica e storia, dunque, a giudizio di Rubasciov, artefice della storia risvegliatosi uomo politico, riposa non solo l’impossibilità ma la sostanziale, scandalosa iniquità di ogni rivoluzione per la quale nessun sacrificio è eccessivo, a partire da quello di coloro nel cui nome (e per la cui felicità futura) si agisce. Per questo è ancora Rubasciov a riassumere la tragicità della contraddizione tra ciò che è e ciò verso cui si vorrebbe tendere (senza tener conto della situazione reale, delle condizioni dell’oggi) nei freddi, esatti, incontestabili termini di un ragionamento matematico: “In quei giorni abbiamo fatto la storia, ora voi fate la politica […]. Un matematico ebbe a dire una volta che l’algebra è la scienza della gente pigra: non si sviluppa x, ma si opera come se lo si sapesse. Nel nostro caso x rappresenta la massa anonima, il popolo. La politica significa operare con questa x senza curarsi della sua vera natura. Fare la storia significa identificare la x con ciò che essa rappresenta nell’equazione”.
Riconosciuto classico della letteratura, Buio a mezzogiorno è un’opera senza tempo, il cui scintillante coraggio non riposa nella denuncia, nel j’accuse, ma nella lucida presa d’atto di una sconfitta. Che è dell’umanità, non di una generazione.
Eccovi l’incipit, buona lettura.
La porta della cella si chiuse con un colpo secco alle spalle di Rubasciov.