Il Circolo di Jena
Recensione di “Magnifici ribelli” di Andrea Wulf
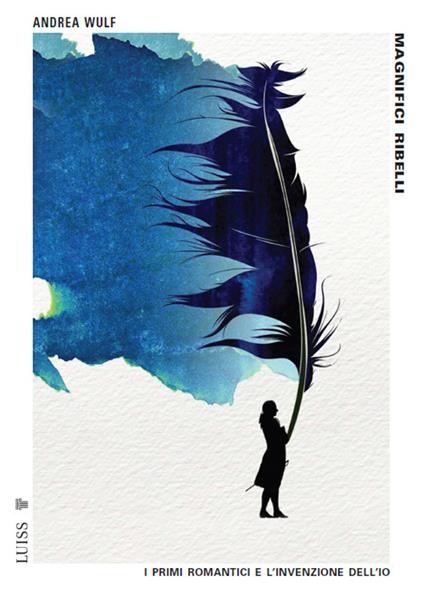
Il secolo XVIII sta volgendo al termine. La Francia è alle prese con le conseguenze,
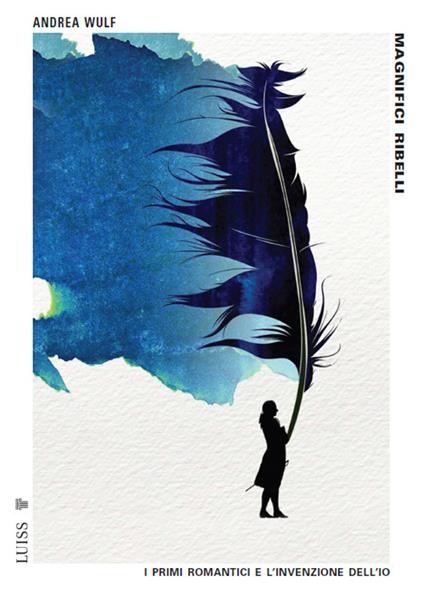
Il secolo XVIII sta volgendo al termine. La Francia è alle prese con le conseguenze,
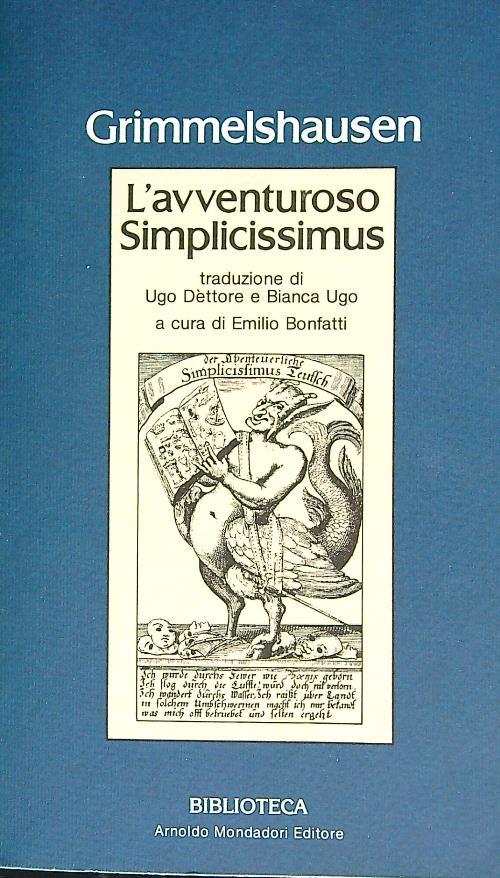
“Nel suo racconto Das Treffen in Telgte Günter Grass si accinge a descrivere un
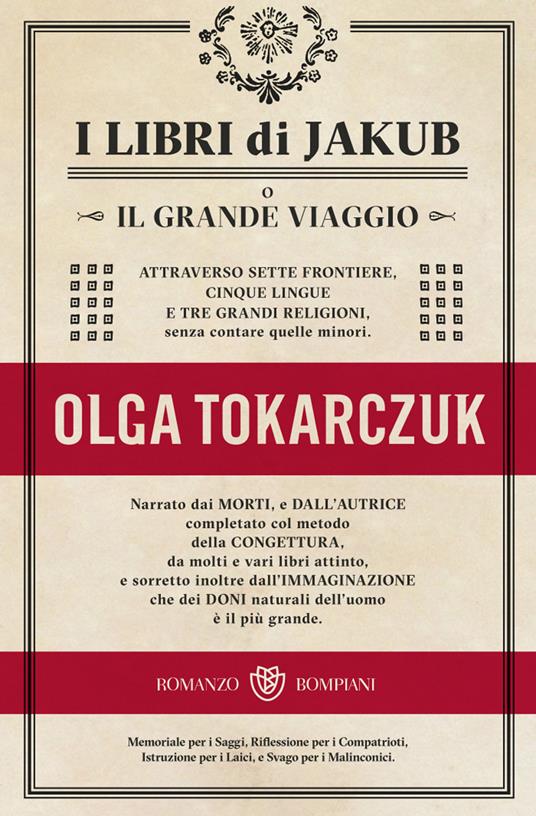
Dio, per antonomasia misterioso e inconoscibile, inafferrabile e oscuro, è, per inevitabile

Francia, 1757, Robert-François Damiens confessa pubblicamente i suoi crimini, poi
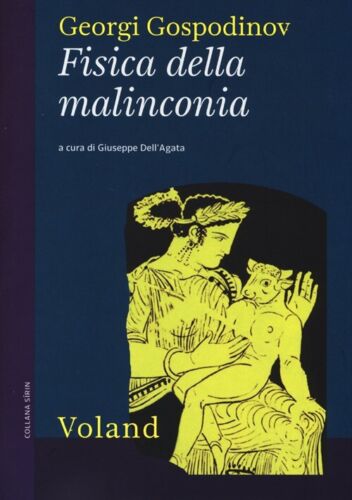
“In questo romanzo il tema dominante della prima parte consiste in un’ipertrofica
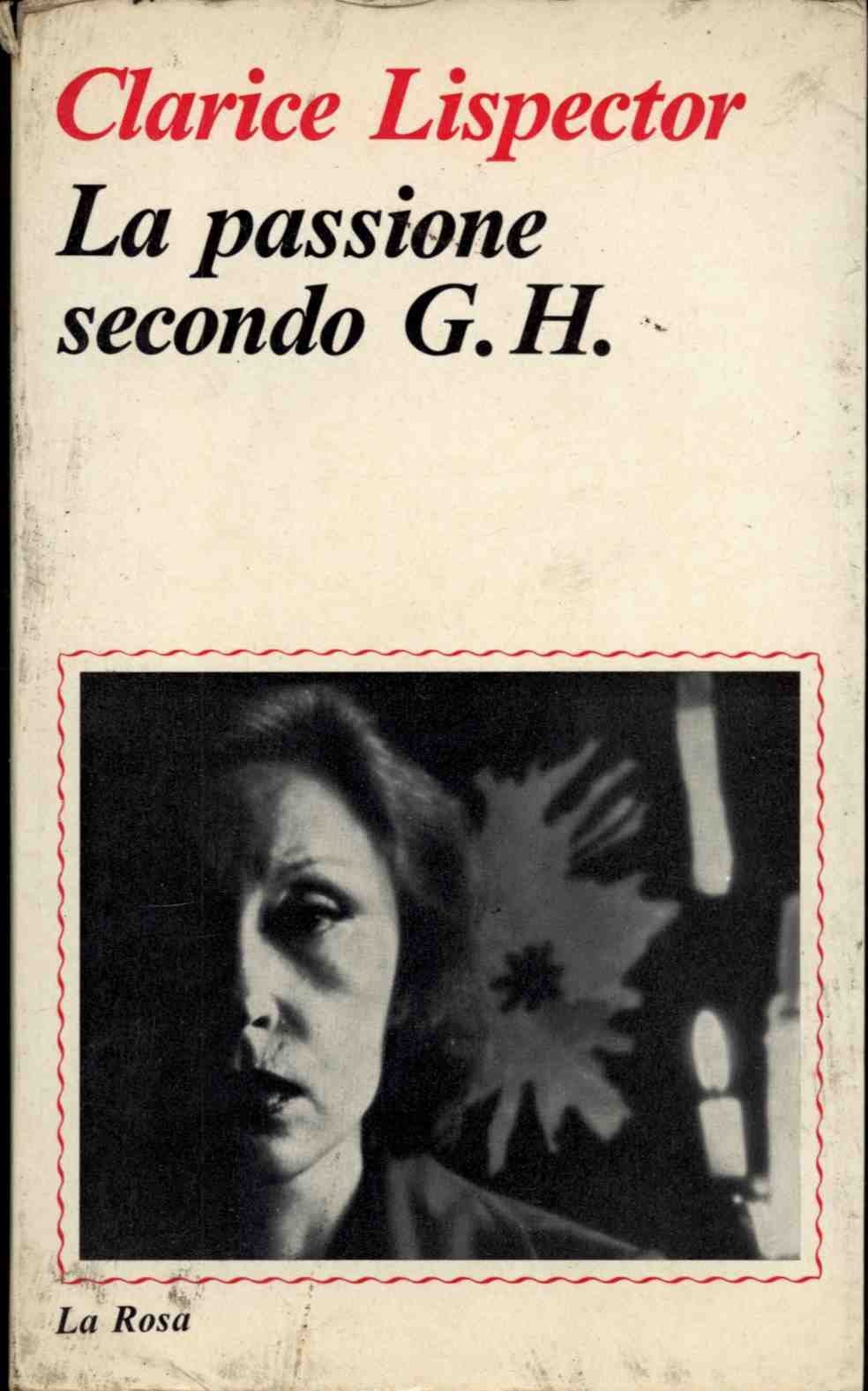
“Figlia di ebrei russi emigrati dall’Ucraina in Brasile negli anni ’20 del secolo [scorso], Clarice
Leggi tutto »Come possedere una moneta e non sapere in quale Paese abbia valore
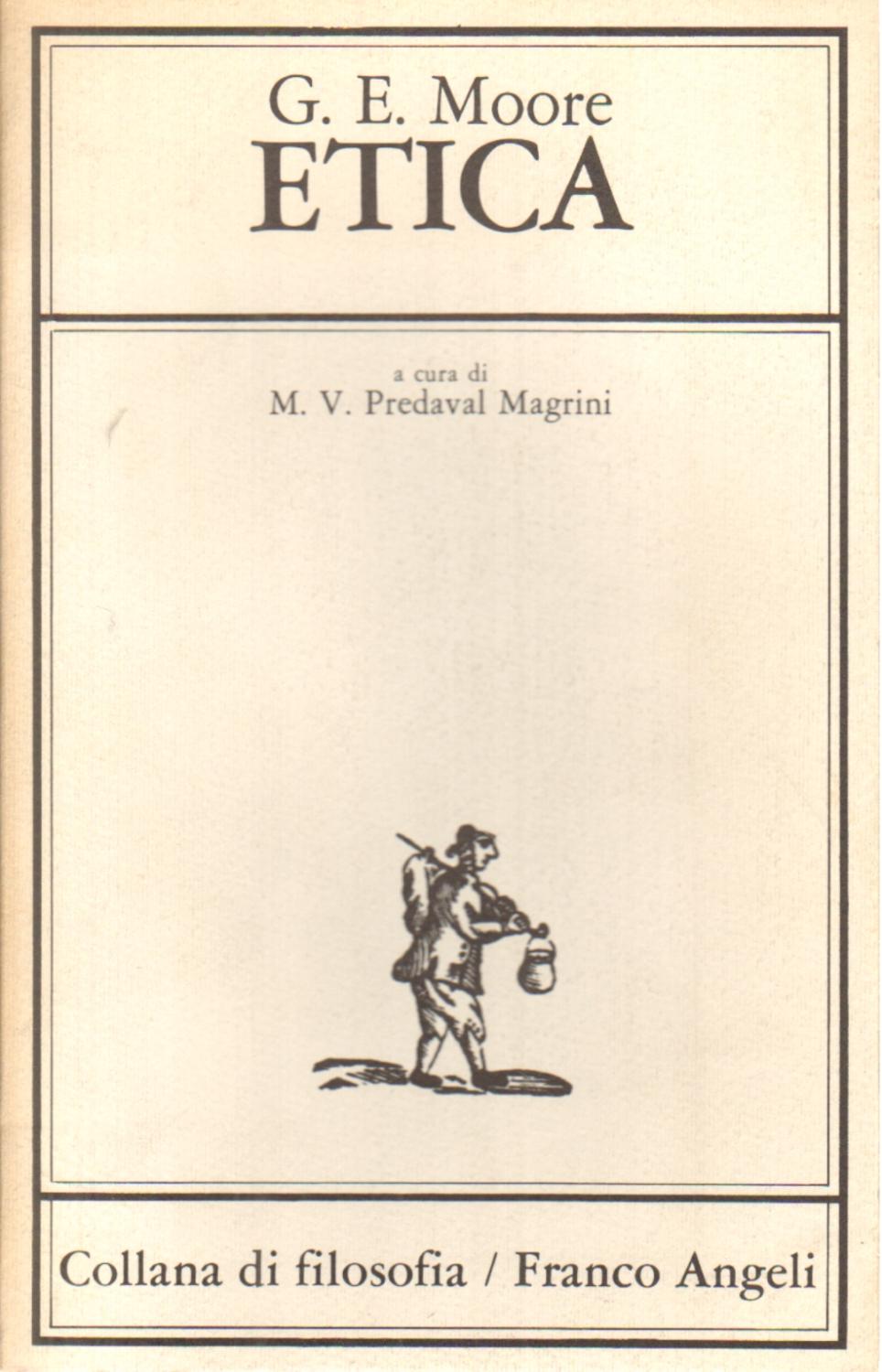
Se una cosa è intrinsecamente buona, la sua esistenza è sempre da considerarsi positiva, anche nel caso in cui la cosa intrinsecamente buona esistesse nel più completo isolamento. Ma cos’è l’intrinsecamente buono? Secondo quanto dichiara il filosofo George Edward Moore nel breve e denso saggio intitolato Etica (in Italia pubblicato da Franco Angeli nella Collana di Filosofia con traduzione e introduzione di Maria Vittoria Predaval Magrini) è un’esperienza che vale la pena di essere vissuta per se stessa.
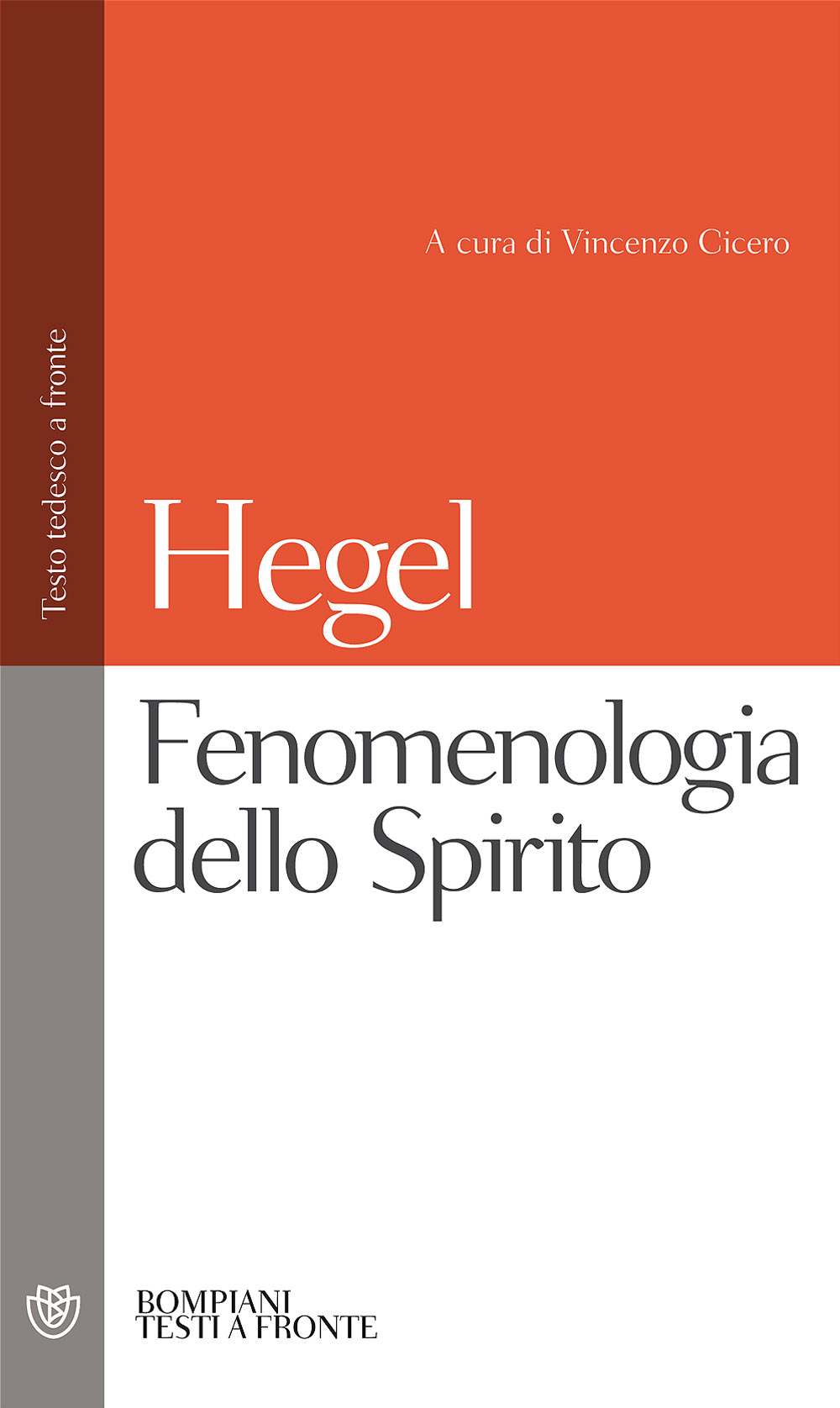
Perché Hegel? Perché affrontare la complessità dell’idealismo e provare a far propria una prospettiva – quella della coscienza, che nel superamento di se stessa e nell’acquisizione di sé come spirito cancella il dualismo tra soggetto e oggetto – che oggi più di ieri appare quasi insensata? Perché, semplicemente, non adottare il punto di vista di Gilbert Ryle e della scuola analitica, che nel rubricare la filosofia hegeliana come errore la qualifica come totalmente inutile?
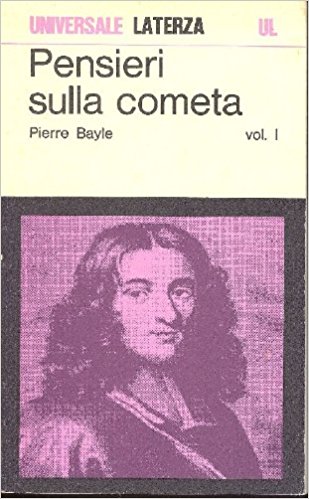
Il Seicento. Il Grand Siècle. La temperie culturale è vivacissima. Baruch Spinoza suscita scandalo e infinite polemiche con la pubblicazione delle sue opere, il Tractatus Theologico-Politicus, l’Ethica more geometrico demonstrata; la legge di gravitazione universale di Isaac Newton spalanca nuovi orizzonti alla scienza; lo stesso Newton e Leibniz giungono, ciascuno per proprio conto (disputandosene poi a muso duro la paternità) alla scoperta del calcolo infinitesimale.
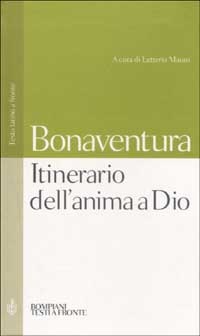
“Boezio si era proposto di tradurre in latino l’intera opera di Platone e di Aristotele e di mostrare la sostanziale concordanza del loro pensiero, ma è noto che egli non riuscì a portare avanti questo programma. Nulla ci è pervenuto delle sue eventuali traduzioni di Platone e, per quanto riguarda le traduzioni aristoteliche, ci sono giunte soltanto quelle delle Categorie e del De Interpretatione […]. Leggi tutto »Ragione e fede sotto il cielo di Dio